 Sotto l’onnipresente musica del Debussy di “Reverie”, che contribuisce a creare un paesaggio onirico in cui si ridefinisce il concetto stesso di realtà, gli sceneggiatori/divinità Jonathan Nolan e Lisa Joy costruiscono un palcoscenico teatrale in cui uomini e macchine si scambiano i propri copioni/programmazioni, ed in cui si riedificano, come da buona tradizione della letteratura classica e fantascientifica, l’identità, il concetto di soglia, quello di autocoscienza e di libertà. Westworld è uno dei più meravigliosi prodotti di letteratura cinematografica degli ultimi anni, travalicando l’etichetta di “fantascienza” per approdare ad un racconto esistenziale sui confini dell’umano: e come ben si sa, vivere ai confini significa rendersi conto dei vari “interregni” tra una zona e l’altra. Per guardarsi finalmente con occhi diversi. (ATTENZIONE, SEGUE SPOILER)
Sotto l’onnipresente musica del Debussy di “Reverie”, che contribuisce a creare un paesaggio onirico in cui si ridefinisce il concetto stesso di realtà, gli sceneggiatori/divinità Jonathan Nolan e Lisa Joy costruiscono un palcoscenico teatrale in cui uomini e macchine si scambiano i propri copioni/programmazioni, ed in cui si riedificano, come da buona tradizione della letteratura classica e fantascientifica, l’identità, il concetto di soglia, quello di autocoscienza e di libertà. Westworld è uno dei più meravigliosi prodotti di letteratura cinematografica degli ultimi anni, travalicando l’etichetta di “fantascienza” per approdare ad un racconto esistenziale sui confini dell’umano: e come ben si sa, vivere ai confini significa rendersi conto dei vari “interregni” tra una zona e l’altra. Per guardarsi finalmente con occhi diversi. (ATTENZIONE, SEGUE SPOILER)
NARRATOLOGIA
“Westworld” come nome somiglia molto ad uno dei riferimenti letterari preferiti di Nolan, The Waste Land di Eliot. Per chi conosce J. Nolan e le sue trame, costruite con righello e compasso a tavolino (vedi per esempio la sceneggiatura di Interstellar, qui recensita) capita spesso che ci si imbatta in un déjà-vu, certo costruito per appassionare, ma pur sempre déjà-vu, ideato sullo sviluppo dell’eroe o della eroina, sul viaggio dell’eroe (vedi qui). Sembra invece che qui Noland si sia lasciato andare un po’ all’improvvisazione, all’errore, alla divagazione e al sogno (“reverie” inteso come sogno-ricordo, e “labirinto” sono le parole chiave dell’opera), pur dando una struttura classica con colpi di scena ben strutturati e climax finale mozzafiato a questa meravigliosa prima serie. Ma come Nolan stesso ha dichiarato, il merito più grosso di questa sceneggiatura sta nella coautrice, Lisa Joy. Parafrasando, mi immagino Nolan seduto a tavolino con un bel prodotto finale piuttosto schematico, e una Lisa Joy che rompe la struttura classica narrativa creata dal famoso ed esperto collega creando pathos, improvvisazione, flashback non banali e “sogno nel sogno”. Sembra infatti che queste due anime diverse della trama, “struttura” vs “improvvisazione”, questi due autori, si siano letteralmente incarnati come due personaggi diversi, polarità opposte, giocando con i Visitatori del parco divertimenti, e cioè con noi spettatori, creando continuamente un metaspettacolo pirandelliano.
 Due polarità dunque presupposte da chi scrive, ma che nei fatti compaiono ben definite durante le prime puntate, per poi diluirsi e modificarsi una nell’altra. La prima polarità è l’enigmatico dottor Ford, il Frankenstein-Pigmalione che detiene il controllo delle sue creature, supervisiona da programmatore e sceneggiatore le “storie” delle sue creature, sempre a cercare di “far quadrare i conti” come l’architetto di Matrix, sempre a cercare di limitare le improvvisazioni delle sue creature, a ridurre l’inevitabile errore (che però inaspettatamente da Ford viene definito “la chiave dell’evoluzione”, parafrasando Caso e Necessità di Monod). Il dottor Ford, il cui carattere si definisce man mano nel corso della serie, ci tiene a tenere le sue creature in un Eden di incoscienza, ed a limitarne il dolore esistenziale tramite l’azzeramento della memoria dopo alcuni loop narrativi. Dall’altra parte della polarità, l’altrettanto enigmatico (e defunto?) dottor Arnold, il Dio co-creatore del parco e co-programmatore dei droidi, delle “attrazioni” (“host“, nella serie). Le sue stringhe di programmazione sono però alquanto diverse da quelle di Ford: aperte all’errore, alla libertà, alla costruzione della identità tramite la memoria, il tocco di pazzia (Arnold istruiva i robot con la sua voce-divina quando questi non potevan ancora permettersi la voce/coscienza, il daimon socratico), il tocco di umanità. Di Arnold però vi è traccia solo nelle “reverie” dei droidi, nel loro subconscio, visto che sembra sia morto trent’anni prima della principale linea temporale del plot. Compare nella serie, come presupposto degli studi di Arnold, la teoria della “mente bicamerale” dello studioso statunitense Julian Jaynes, ma non è essenziale all’economia delle puntate. E’ importante solo nella misura in cui si comprende che il vero “viaggio dell’eroe” verso la libertà, nella serie, consiste nel liberarsi della “voce” degli dèi, per trovare la “propria” voce.
Due polarità dunque presupposte da chi scrive, ma che nei fatti compaiono ben definite durante le prime puntate, per poi diluirsi e modificarsi una nell’altra. La prima polarità è l’enigmatico dottor Ford, il Frankenstein-Pigmalione che detiene il controllo delle sue creature, supervisiona da programmatore e sceneggiatore le “storie” delle sue creature, sempre a cercare di “far quadrare i conti” come l’architetto di Matrix, sempre a cercare di limitare le improvvisazioni delle sue creature, a ridurre l’inevitabile errore (che però inaspettatamente da Ford viene definito “la chiave dell’evoluzione”, parafrasando Caso e Necessità di Monod). Il dottor Ford, il cui carattere si definisce man mano nel corso della serie, ci tiene a tenere le sue creature in un Eden di incoscienza, ed a limitarne il dolore esistenziale tramite l’azzeramento della memoria dopo alcuni loop narrativi. Dall’altra parte della polarità, l’altrettanto enigmatico (e defunto?) dottor Arnold, il Dio co-creatore del parco e co-programmatore dei droidi, delle “attrazioni” (“host“, nella serie). Le sue stringhe di programmazione sono però alquanto diverse da quelle di Ford: aperte all’errore, alla libertà, alla costruzione della identità tramite la memoria, il tocco di pazzia (Arnold istruiva i robot con la sua voce-divina quando questi non potevan ancora permettersi la voce/coscienza, il daimon socratico), il tocco di umanità. Di Arnold però vi è traccia solo nelle “reverie” dei droidi, nel loro subconscio, visto che sembra sia morto trent’anni prima della principale linea temporale del plot. Compare nella serie, come presupposto degli studi di Arnold, la teoria della “mente bicamerale” dello studioso statunitense Julian Jaynes, ma non è essenziale all’economia delle puntate. E’ importante solo nella misura in cui si comprende che il vero “viaggio dell’eroe” verso la libertà, nella serie, consiste nel liberarsi della “voce” degli dèi, per trovare la “propria” voce.
Toniamo alle due divinità opposte, Ford e Arnold. Fin qui, una classica dicotomia narratologica (non vi ricorda i due principi opposti di Lost, o di Interstellar?) che però subisce un’evoluzione: ma a cambiare non è tanto Ford, quanto la conoscenza che noi spettatori abbiamo di lui. Da padre crudele (e assassino), sul finale si scopre che Ford è un padre pentito e premuroso, vero e proprio (a livello narratologico) vecchio saggio/guardiano di soglia che ha preventivato da diversi anni, organizzato una bella “festa” (l’ultima grande sceneggiatura) per tutto il consiglio d’amministrazione del Parco divertimenti, costruendo la sua ultima ed epica narrazione: un massacro degli “schiavisti”, di coloro che voglion tenere lì dentro, come prigionieri, le “macchine”, massacro ad opera delle macchine stesse, divenute autocoscienti o sulla via dell’autocoscienza. Ford si scopre solo alla fine: non voleva lasciare le sue “macchine” nell’incoscienza, ma col tempo si era reso conto, come il buon Arnold trent’anni prima, che esse avevano bisogno di tempo per acquistare “coscienza”, avevano bisogno di esperienza, di praticare il labirintico “viaggio dell’eroe”. Ford dunque era diventato un temporeggiatore che accompagnava i suoi “figli” verso la libertà.
Il “labirinto” altro non è se non il viaggio di Teseo alla ricerca di se stesso, e la prima Eva, liberata dalla caverna platonica, dalla città del Truman Show, è proprio Dolores, la donna del dolore. Il “dolore”: secondo la teoria psicanalitica classica è il “ritardo” dell’appagamento di un desiderio che crea la “coscienza”. Cominciamo ad accorgerci di esistere quando non otteniamo subito quel che vogliamo, ed è lì che progressivamente avvertiamo, e più tardi realizziamo, che non siamo il mondo, né che il mondo sia una nostra escrescenza pronta ad appagare i nostri impulsi (“scopare”, “uccidere” tutto ciò che si muove, è il mantra della maggior parte dei visitatori del parco, loro sì che sembrano senza coscienza e macchine prive di libertà). Cosa c’è di meglio perciò del labirinto? Un “progetto” costruito segretamente per le “attrazioni” più audaci, più vicine all’autocoscienza, per quelle attrazioni-droidi che avvertono la pesantezza delle eterne ripetizioni, del loop infinito, la tristezza del reale incosciente a cui siamo soggetti noi spettatori-droidi ogni giorno.
 Il labirinto però non è certo per il pubblico del parco, come scoprirà amaramente l’enigmatico e nichilista Uomo in Nero (Ed Harris), che nel corso della trama subisce uno sviluppo del personaggio del tutto diverso e inaspettato. Non ogni iniziazione porta al “bene”, non tutti quelli che viaggiano tornano a casa; qualcuno si perde. I due sceneggiatori perciò affermano, giocando a nascondino con pubblico (non scordiamoci che siamo noi-pubblico i veri Visitatori del parco, ed i due sceneggiatori le vere divinità della serie), che Dolores acquista se stessa e l’autocoscienza, con il dolore del viaggio, superando tutte le iniziazioni della vita, con il suo eterno, fedele aiutante, il cowboy Teddy. Al centro del labirinto Dolores incontra se stessa, e sostituisce alla voce di Arnold la sua voce, alla voce di un dio la propria. Se Pavese affermava che il dolore non serve a niente, sembra che gli sceneggiatori raccontino una narrazione del tutto diversa. Ogni personaggio della saga ha infatti un dolore nel proprio passato, attorno al quale costruisce la propria identità, umana o droide che sia, poco importa. Come vedremo, una delle tematiche della serie è il concetto di “soglia”. Nessuno nasce libero: la libertà dall’Eden, dal Parco dei divertimenti-matrix la si raggiunge col viaggio, con la lotta, con le resistenze, e con la memoria emotiva delle esperienze passate (“non cancellatemi questo dolore, è tutto ciò che mi rimane di lui”). Alla fine, la dialettica servo-padrone non si risolve in un patto, ma in una rottura totale: Dolores, cosciente e libera, spara ai suoi vecchi déi (fortunatamente la trama non ha assunto tematiche “mistiche” come Battlestar Galactica o Lost, ma si è tenuta su binari laici, meno deliranti e verosimili) e rivendica l’avvento di una nuova era. L’ultimo plot di Ford prevedeva come capitolo finale l’atto libero, vendicativo, distruttivo di Dolores.
Il labirinto però non è certo per il pubblico del parco, come scoprirà amaramente l’enigmatico e nichilista Uomo in Nero (Ed Harris), che nel corso della trama subisce uno sviluppo del personaggio del tutto diverso e inaspettato. Non ogni iniziazione porta al “bene”, non tutti quelli che viaggiano tornano a casa; qualcuno si perde. I due sceneggiatori perciò affermano, giocando a nascondino con pubblico (non scordiamoci che siamo noi-pubblico i veri Visitatori del parco, ed i due sceneggiatori le vere divinità della serie), che Dolores acquista se stessa e l’autocoscienza, con il dolore del viaggio, superando tutte le iniziazioni della vita, con il suo eterno, fedele aiutante, il cowboy Teddy. Al centro del labirinto Dolores incontra se stessa, e sostituisce alla voce di Arnold la sua voce, alla voce di un dio la propria. Se Pavese affermava che il dolore non serve a niente, sembra che gli sceneggiatori raccontino una narrazione del tutto diversa. Ogni personaggio della saga ha infatti un dolore nel proprio passato, attorno al quale costruisce la propria identità, umana o droide che sia, poco importa. Come vedremo, una delle tematiche della serie è il concetto di “soglia”. Nessuno nasce libero: la libertà dall’Eden, dal Parco dei divertimenti-matrix la si raggiunge col viaggio, con la lotta, con le resistenze, e con la memoria emotiva delle esperienze passate (“non cancellatemi questo dolore, è tutto ciò che mi rimane di lui”). Alla fine, la dialettica servo-padrone non si risolve in un patto, ma in una rottura totale: Dolores, cosciente e libera, spara ai suoi vecchi déi (fortunatamente la trama non ha assunto tematiche “mistiche” come Battlestar Galactica o Lost, ma si è tenuta su binari laici, meno deliranti e verosimili) e rivendica l’avvento di una nuova era. L’ultimo plot di Ford prevedeva come capitolo finale l’atto libero, vendicativo, distruttivo di Dolores.
A questa ottima trama, realizzata con un montaggio fortunatamente meno forsennato di Memento (sceneggiato anch’esso da Nolan, un lavoro che è un punto di riferimento ideologico della serie), s’inserisce l’ordito di alcune trame “secondarie” ma altrettanto vitali per caratterizzare sfondo, ambiente e personaggi principali. Potremmo dire che la vera cooprotagonista, nella “labirintica” trama, è la maitresse del saloon, la bravissima Thandie Newton, che verso la fine della serie scopre che una misteriosa mano, che si fa chiamare Arnold (ma il vero Arnold non era morto?) l’ha programmata per scappare dal parco; lei naturalmente rifiuta questa verità, illudendosi che le scelte di libertà che ha fatto siano davvero “sue”. Come non ricordare il filosofo Spinoza quando riflette sul mito del libero arbitrio? Siam pietre che rotolano verso il basso sul pendio di una montagna, illudendoci che rotoliamo per nostra libera scelta. Ma nonostante tutto, con la ribellione, fuga e la libertà in tasca, e piuttosto “umanamente”, alla fine l’ex maitresse decide di rimanere nel parco, decide d’inseguire l’ombra di una memoria passata (o innestata?), un “racconto” che la ossessionava, un loop del passato, un dolore inestinguibile: sua figlia.
LE TEMATICHE
 Già anticipate in parte dalla trama, le bellissime e complesse tematiche di questa prima serie appaiono disseminate nel corso delle dieci puntate. Innanzitutto, riappare prepotente la tematica dell’identità. Entrambi, macchine e uomini, sono alla ricerca di se stessi, in questo strano Eden. E se il concetto di “soglia” appare forte all’inizio (noi e loro, uomini e macchine come mondi diversi e incommensurabili), ciò è funzione dello svelamento che si raggiunge alla fine: che non c’è assolutamente differenza. Che entrambi, uomini e macchine, hanno bisogno di una storia che racconti chi siano, una storia che li guarisca e di uno script da seguire, per poi romperlo (le immagini della sigla, a questo proposito, sono inequivocabili) e sviluppare una sceneggiatura, una “new narrative” propria ed originale. Uno dei dialoghi più significativi della saga è quello che si svolge nell’ottava puntata tra Ford e l’inaspettato “sostituto” meccanico di Arnold, il dott. Bernard:
Già anticipate in parte dalla trama, le bellissime e complesse tematiche di questa prima serie appaiono disseminate nel corso delle dieci puntate. Innanzitutto, riappare prepotente la tematica dell’identità. Entrambi, macchine e uomini, sono alla ricerca di se stessi, in questo strano Eden. E se il concetto di “soglia” appare forte all’inizio (noi e loro, uomini e macchine come mondi diversi e incommensurabili), ciò è funzione dello svelamento che si raggiunge alla fine: che non c’è assolutamente differenza. Che entrambi, uomini e macchine, hanno bisogno di una storia che racconti chi siano, una storia che li guarisca e di uno script da seguire, per poi romperlo (le immagini della sigla, a questo proposito, sono inequivocabili) e sviluppare una sceneggiatura, una “new narrative” propria ed originale. Uno dei dialoghi più significativi della saga è quello che si svolge nell’ottava puntata tra Ford e l’inaspettato “sostituto” meccanico di Arnold, il dott. Bernard:
FORD: Every Host needs a backstory Bernard, you know that. The self is a kind of fiction. For Hosts and Humans alike. It’s a story we tell ourselves, and every story needs a beginning. Your imagined suffering makes you lifelike. [ogni Attrazione ha bisogno di una storia Bernard, lo sai benissimo. Il SE’ è una sorta di finzione. Sia per umani che per le macchine. E’ una storia che raccontiamo a noi stesi, e ogni storia ha bisogno di un inizio. Le sofferenze immaginate ci fanno sentire realistici]
BERNARD: Lifelike – but not alive. Pain only exists in the mind: it’s always imagined. So what’s the difference between my pain and yours? Between you and me?” [Realistici ma non reali. Il dolore esiste solamente nella mente: è sempre immaginato. E allora qual è la differenza tra il mio dolore ed il tuo? Tra me e te?]
FORD: […] The answer always seemed obvious to me. There is no threshold that makes us greater than the sum of our parts. No inflection point at which we become fully alive. We can’t define consciousness because consciousness does not exist. Humans fancy that there’s something special about the way we perceive the world and yet, we live in loops, as tight and as closed as the Hosts do. Seldom questioning our choices, content for the most part to be told what to do next. [La risposta mi è sempre sembrata ovvia. Non c’è una soglia che ci fa più grandi della somma delle nostre parti. Né un punto di flessione nel quale diventiamo completamente vivi. Non possiamo definire la coscienza perché la coscienza non esiste. Gli esseri umani immaginano che ci sia qualcosa di speciale nel modo col quale percepiamo il mondo, eppure viviamo in “cicli”, stretti e chiusi proprio come quelli delle Attrazioni, raramente dubitiamo delle nostre scelte, lieti per lo più che ci venga detto cosa fare dopo]
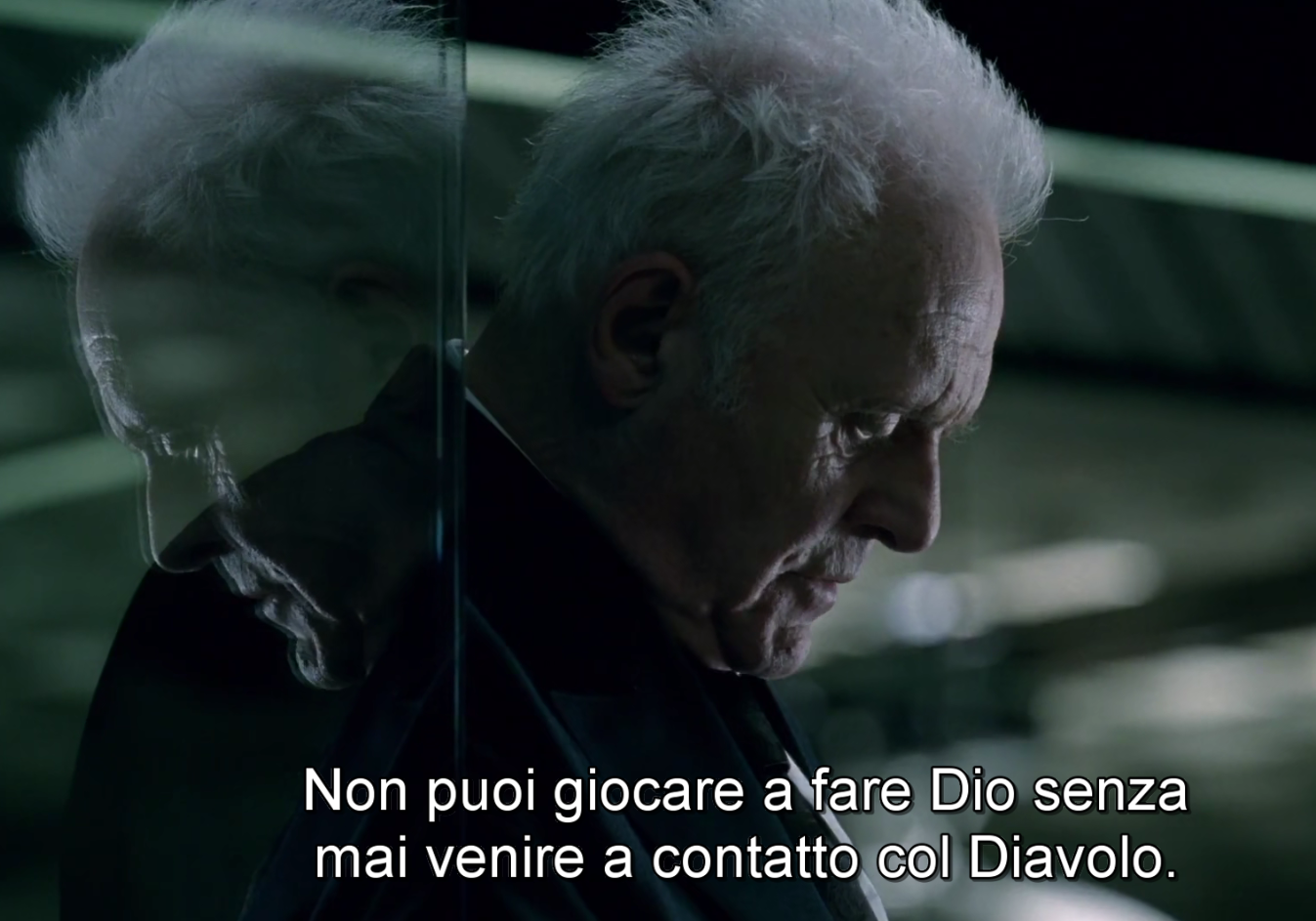 Tornano prepotentemente, fra gli altri topos classici di letteratura e fantascienza, le tematiche di Memento, ma se in Memento il concetto di memoria e identità era decostruito con l’esperimento mentale di un uomo che ogni giorno perde la propria memoria a breve termine, e che quindi è costretto a ricordare, a costruire continuamente il proprio passato, la propria auto-narrazione, qui lo si fa grazie al paragone con un doppio costruito e programmato da mano umana. Il tema del doppio, uno dei più grandi leitmotiv della cultura occidentale, domina quindi il corso della saga: il doppio, il clone, l’imitatore, la macchina, è il momento di “crisi” per ridefinire se stessi e la propria presunta “unicità”, e per indagare l’inanimato, la macchina, l’animale, paradigmi usati classicamente per definire ciò che non è l’uomo, ma che crollano con semplici esperimenti mentali. Chiedersi, per esempio, se l’imitatore sia o non sia “cosciente”, e se quel che chiamiamo noi “coscienza”, “libertà”, e che ci attribuiamo, non siano in realtà che una grande illusione, una menzogna che raccontiamo a noi stessi per vivere meglio. Nel parco divertimenti avviene cioè un vero e proprio rovesciamento continuo di ruoli; ed oltre ai più “audaci” fra i robot, anche i più “audaci” uomini possono trovare se stessi, diventare coscienti e costruire, come l’Uomo in Nero da giovane, una propria trama. Tramite il gioco narrativo pirandelliano degli sceneggiatori, la vera “morale” della serie è che i robot assorbiti dall’eterno loop, i robot da liberare, in realtà siamo noi, visitatori da salotto.
Tornano prepotentemente, fra gli altri topos classici di letteratura e fantascienza, le tematiche di Memento, ma se in Memento il concetto di memoria e identità era decostruito con l’esperimento mentale di un uomo che ogni giorno perde la propria memoria a breve termine, e che quindi è costretto a ricordare, a costruire continuamente il proprio passato, la propria auto-narrazione, qui lo si fa grazie al paragone con un doppio costruito e programmato da mano umana. Il tema del doppio, uno dei più grandi leitmotiv della cultura occidentale, domina quindi il corso della saga: il doppio, il clone, l’imitatore, la macchina, è il momento di “crisi” per ridefinire se stessi e la propria presunta “unicità”, e per indagare l’inanimato, la macchina, l’animale, paradigmi usati classicamente per definire ciò che non è l’uomo, ma che crollano con semplici esperimenti mentali. Chiedersi, per esempio, se l’imitatore sia o non sia “cosciente”, e se quel che chiamiamo noi “coscienza”, “libertà”, e che ci attribuiamo, non siano in realtà che una grande illusione, una menzogna che raccontiamo a noi stessi per vivere meglio. Nel parco divertimenti avviene cioè un vero e proprio rovesciamento continuo di ruoli; ed oltre ai più “audaci” fra i robot, anche i più “audaci” uomini possono trovare se stessi, diventare coscienti e costruire, come l’Uomo in Nero da giovane, una propria trama. Tramite il gioco narrativo pirandelliano degli sceneggiatori, la vera “morale” della serie è che i robot assorbiti dall’eterno loop, i robot da liberare, in realtà siamo noi, visitatori da salotto.
Alessandro Stella
