Estratto da Domenico Losurdo, Con Gramsci oltre Marx e oltre Gramsci, in «Critica Marxista», n. 5-6, 1997, pp. 56-66; ora in Giorgio Baratta – Guido Liguori (eds.), Gramsci da un secolo all’altro, Editori Riuniti, Roma, 1999, pp. 95-112.
“Perché, nonostante la disfatta del «socialismo reale» e la conclusione del ciclo storico nell’ambito del quale dobbiamo pur collocare Gramsci, egli continua a rivelare grande vitalità e forza suggestiva, tanto da esser letto e discusso anche in ambienti politici ben lontani dal marxismo e dal comunismo e in contesti culturali e geografici assai remoti rispetto all’Italia? Si tenta talvolta di staccare questo straordinario autore dalla storia tragica del comunismo novecentesco. Ma un tale approccio è fuorviante. Già come pensatore, Gramsci mostra chiaramente di aver fatto tesoro della lezione di Hegel e di Marx: filosofare significa pensare concettualmente il proprio tempo; elaborare un pensiero e un progetto di emancipazione significa tracciare un bilancio storico dei movimenti di emancipazione concretamente emersi e sviluppatisi. Ma oltre che pensatore, Gramsci è stato anche dirigente comunista di primo piano: non può essere trasformato in una sorta di Horkheimer o di Adorno italiano, impegnato a costruire una teoria critica senza rapporto o con un rapporto esclusivamente polemico nei confronti del movimento comunista e del «movimento reale» di trasformazione della società. […]”
“E, sulla collocazione privilegiata di Gramsci nell’ambito del marxismo novecentesco, conviene intanto tener presente che l’Italia del tempo è un punto alto del dibattito filosofico e politico, e non solo per la presenza di Croce e Gentile. Si pensi a Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto e Roberto Michels, cioè agli elitisti che hanno elaborato o contribuito in modo considerevole ad elaborare la teoria della democrazia oggi dominante. Sono questi gli autori che Schumpeter ha alle spalle allorché definisce la democrazia come una leadership concorrenziale garantita dal mercato politico. Espunta è dalla definizione di questo regime politico ogni idea di emancipazione e di partecipazione popolare al potere. Come il mercato economico consente ai consumatori di scegliere liberamente tra diversi prodotti, così il mercato politico consente ai consumatori-elettori di scegliere liberamente tra diversi leaders ediverse élites. Fuori discussione resta l’avvicendarsi delle élites, rispetto alle quali le masse popolari continuano ad essere una «moltitudine bambina» che ora è possibile controllare e governare attraverso strumenti di comunicazione e di manipolazione sempre più potenti e irresistibili. Si potrebbe dire che tutta la riflessione filosofica e politica in Gramsci è un tentativo di rispondere alla sfida costituita dall’elitismo e dalla teoria elitista della democrazia: si tratta di far sì che il «popolo lavoratore» non rimanga nella condizione di «preda buona per tutti», di semplice «materiale umano»,di «materiale grezzo per la storia delle classi privilegiate». Tale condizione risulta insuperabile fino a quando le classi subalterne continuano ad essere una «massa amorfa che ondeggia perennemente fuori di ogni organizzazione spirituale».

Epperò questa «organizzazione spirituale» e politica si configura come un processo che può essere interrotto e spezzato dall’iniziativa dell’élite dominante, la quale può cooptare al suo interno gli elementi più capaci e più pericolosi delle classi subalterne. Si spiega così, secondo Pareto, l’evoluzione del «socialista “intellettuale” e “trasformista”» Bissolati che, in occasione della guerra libica e poi del primo conflitto mondiale, fa proprie le parole d’ordine colonialiste e interventiste della borghesia. Si comprende allora il problema attorno a cui si arrovellano in particolare i Quaderni del carcere: come impedire all’élite dominante di decapitare, ideologicamente epoliticamente, il movimento di emancipazione delle classi e dei popoli tenuti in condizione subalterna dal sistema dominante? Tali decapitazioni risultano agevoli anche per il fatto che «generalmente» -osserva Pareto- i movimenti rivoluzionari degli «strati inferiori» sono «capitanati da individui degli strati superiori». E di nuovo vediamo Gramsci cimentarsi, in modo al tempo stesso rigoroso e appassionato, coi problemi sollevati dal geniale teorico dell’elitismo: come evitare che, durante le «grandi “svolte” storiche», gli intellettuali «formatisi» sul «terreno» del movimento operaio ritornino alle «classi intermedie tradizionali» da cui provengono? […]
Ora il pensiero corre non più a Bissolati, bensì a Mussolini e agli anarco-sindacalisti che passano al nazionalismo e al fascismo, un fenomeno a cui anche i Quaderni del carcere dedicano notevole attenzione a dimostrazione dell’estrema difficoltà per il proletariato di un ceto di intellettuali e dirigenti ad esso legato in modo stabile e organico. D’altro canto, è lo stesso Mussolini a vantarsi, nel 1919 e nel 1924,della sua parabola ideologica e politica, di essere un «eretico» espulso dalla «chiesa ortodossa» del socialismo, nel quale aveva comunque da giovane immesso, lui per primo, la lezione di Blanqui. Gramsci non solo condanna il «blanquismo di questo epilettico», ma esprime anche un giudizio complessivo: «Il blanquismo, nella sua materialità, può essere oggi sovversivo, domani reazionario, ma giammai rivoluzionario».
L’articolo, pubblicato su «L’Ordine Nuovo» del 22 giugno 1921, porta il titolo Sovversivismo reazionario. Il sovversivismo non è di per sé sinonimo di rivoluzione o di rinnovamento. I Quaderni del carcere richiamano l’attenzione sul fatto che «le frasi di “ribellismo”, di“sovversivismo”, di “antistatalismo” primitivo ed elementare» sono espressione di«apoliticismo», e dunque di rinuncia, di accettazione o interiorizzazione di una situazione di subalternità. In realtà, «scarsa comprensione dello Stato significa scarsa coscienza di classe». Una classe subalterna dimostra di essere matura per la conquista del potere solo allorché si rivela in grado di costruire concretamente un «ordine nuovo». Comincia ad emergere il carattere originale del pensiero di Gramsci e della sua collocazione nell’ambito della tradizione marxista. A definire tale originalità non è solo l’attenzione al problema della democrazia, certo non estranea a Marx, Engels e Lenin. Epperò, in questi autori il problema della democrazia si affaccia, si presenta talvolta anche con forza, ma per dileguare immediatamente. Col superamento degli antagonismi di classe e delle classi sociali, è destinato ad estinguersi lo Stato e dunquela democrazia, essa stessa una forma di Stato.
Alle spalle della tesi, ovvero dell’illusione, di Marx e Engels c’è un drammatico bilancio storico. In Francia, la Prima Repubblica, nata sull’onda della rivoluzione del 1789, si trasforma nella dittatura e, poi, nell’impero di Napoleone I; la Seconda Repubblica, scaturita dalla rivoluzione del 1848 cede poi il posto alla dittatura bonapartistica di Napoleone III. Per quanto riguarda l’Inghilterra, in situazioni di crisi la classe dominante procede agevolmente alla sospensione dell’habeas corpus e delle garanzie costituzionali e sottopone ad una sorta di stato d’assedio permanente l’Irlanda riottosa al dominio imperiale britannico. E dunque, col verificarsi o il profilarsi di una situazione di crisi, lo Stato liberale e democratico non ha difficoltà a trasformarsi in una dittatura aperta e persino terroristica. A maggior ragione s’impone questa conclusione per Lenin. Con lo scoppio della prima guerra mondiale, il dirigente bolscevico vede anche gli Stati di più consolidata tradizione liberale procedere ad una totale irreggimentazione della popolazione e trasformarsi in Moloch sanguinari inoccasione della prima guerra mondiale che, col ricorso alla legge marziale, ai plotoni d’esecuzione e, talvolta, alla pratica della decimazione, impongono il sacrificio inmassa dei loro cittadini sull’altare della volontà di potenza e del dominio imperialistico. Benché comprensibile nella sua genesi storica e psicologica, la tesi dell’estinzione dello Stato sembra sfociare nella visione escatologica di una società priva di conflitti e, conseguentemente, non bisognosa di norme giuridiche capaci di limitarli e regolamentarli. Del carattere astrattamente utopistico della loro parola d’ordine sembrano in certi momenti rendersi conto Marx e Engels che, con significativa oscillazione, talvolta parlano di abolizione o estinzione dello Stato in quanto tale,talaltra dello «Stato nell’attuale senso politico» ovvero del «potere politico propriamente detto». D’altro canto, secondo la loro stessa analisi, oltre ad essere uno strumento del dominio di classe, lo Stato è anche una forma di «garanzia reciproca», di «assicurazione reciproca» tra gli individui della classe dominante. Non si comprende allora perché, dopo lo scomparsa delle classi e della lotta di classe, dovrebbe diventare superflua la «garanzia» o l’«assicurazione» da fornire ai singoli membri di una comunità unificata. In ogni caso, l’attesa del dileguare di ogni conflitto e dell’estinzione dello Stato e del potere politico in quanto tale rende impossibile la soluzione del problema della trasformazione in senso democratico dello Stato scaturito dalla rivoluzione socialista;questa attesa favorisce l’emergere o il permanere di un atteggiamento fatto di«sovversivismo» banale e inconcludente, incapace di conferire concretezza e stabilità all’emancipazione delle classi subalterne.
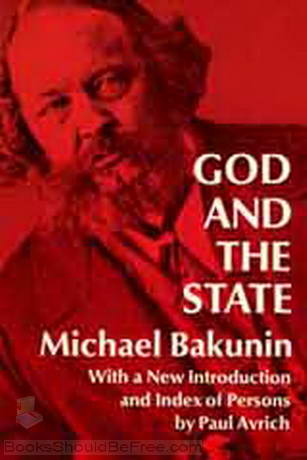
Gramsci si dimostra piuttosto critico nei confronti delle tendenze anarchiche e messianiche. Il socialismo viene visto dal pensatore dell’ «Ordine Nuovo» non come l’inizio del processo di estinzione, bensì come la costruzione dello «Stato sociale del lavoro e della solidarietà»; e non può essere diversamente, dato che «non esiste società se non in uno Stato». Si tratta, secondo i Quaderni di trovare una forma di organizzazione della società che, superando ogni antagonismo di classe, sappia fare a meno dell’apparato di repressione, costruito in vista della guerra di classe all’interno e dello scontro armato con altre classe sfruttatrici concorrenti a livello internazionale. Ma tale forma di organizzazione della società comunista è essa stessa una forma di Stato: «L’elemento Stato-coercizione si può immaginare esaurientesi man mano che si affermano elementi sempre più cospicui di società regolata (o Stato etico o società civile)».
Naturalmente, non mancano dichiarazioni che vanno in direzione diversa e contrastante e che prospettano cioè uno «sparire» dello Stato e il «riassorbimento della società politicanella società civile»; è tuttavia da tener presente che per Gramsci la «società civile […] è anch’essa “Stato”, anzi è lo Stato stesso», e dunque resta da vedere fino a che punto il «riassorbimento della società politica nella società civile» comporta l’avvento di una società realmente senza Stato. I Quaderni del carcere mettono esplicitamente in guardia contro l’«errore teorico» che, nell’indagare il rapporto tra società civile e Stato, trasforma una «distinzione metodica» in «distinzione organica», dimenticando che «nella realtà effettuale società civile e Stato si identificano». Ma non è per l’appunto inquesto errore che incorre la tesi dell’estinzione dello Stato?
Per un verso, la presa di distanza da questo mito è la condizione preliminare per pensare realmente – hegelianamente -la negazione determinata (non quella indeterminata che si esprime nel messianismo e nell’anarchismo) dell’ordinamento esistente, il progetto e il processo di costruzione di una società post-capitalistica; per un altro verso, tale presa di distanza consente una comprensione più completa e più profonda della stessa società capitalistica, che ora è possibile indagare alla luce di una fenomenologia del potere più ricca e più concreta. Certo, per quanto riguarda quest’ultimo punto, Gramsci si colloca sulla scia di Marx ed Engels che, a tale proposito, si differenziano nettamente dalla tradizione liberale. Questa individua il luogo del dominio e della sopraffazione esclusivamente nello Stato, sicché l’emancipazione non può consistereche nella progressiva riduzione della presenza dello Stato. Il Manifesto del partito comunista sorprende invece all’interno della fabbrica capitalistica un «dispotismo» di carattere militare, rispetto al quale l’intervento dello Stato, e persino dello Stato borghese, può costituire un ostacolo e un contrappeso. Epperò, in più occasioni, Engels celebra gli USA come il paese in cui l’«abolizione dello Stato» è già realizzata, almeno nel senso «borghese» del termine. Nessuna attenzione sembra essere riservata alla sorte degli indios e a quella dei neri, prima sottoposti a schiavitù e, negli anni successivi alla guerra di Secessione, costretti ad un regime di apartheid e di whitesupremacy che giunge sino alle forme più efferate di linciaggio. Negli USA della fine dell’Ottocento, è forse debole lo Stato (centrale), ma è tanto più forte il Ku Klux Klan, espressione certo della società civile, la quale però è essa stessa il luogo dell’esercizio del potere, e di un potere assai brutale. Nel 1883, la Corte Suprema dichiara incostituzionale una legge federale che pretende di vietare la segregazione dei neri sui luoghi di lavoro o sui servizi (le ferrovie) gestiti da compagnie private, per definizione sottratti ad ogni interferenza statale. Nella misura in cui sussiste un argine alla sopraffazione a danno dei neri e degli indios, esso risiede nel potere politico centrale, di cui Engels celebra l’estinguersi o il dileguare! Il fatto è che nei testi sopra citati, il luogo della violenza e del dominio viene identificato esclusivamente nello Stato, e il luogo della libertà nella società civile, proprio come nella fenomenologia del potere cara alla tradizione liberale.
Ben più feconda, ai fini della comprensione della storia degli USA e del mondo contemporaneo in genere, si rivela la tesi di Gramsci secondo cui la società civile è essa stessa una forma di Stato. A questo punto, il problema dell’emancipazione diventa piùcomplesso e più drammatico. Se anche fosse possibile, l’estinzione dello Stato non sarebbe di per sé sinonimo di emancipazione, dato che la società civile può bene sprimere una carica di violenza e sopraffazione non inferiore a quella dispiegata delloStato politico, anzi tanto più priva di scrupoli, in quanto suscettibile di dispiegarsi senza impacci, senza neppure la preoccupazione di mantenere la forma o la parvenza dell’imparzialità.
All’attesa dell’estinzione dello Stato s’intreccia spesso, nell’ambito della tradizione marxista, la rivendicazione della democrazia diretta. Questo tema da un lato è in stridente contraddizione col primo (per diretta che sia, la democrazia è pur sempre una forma di Stato), dall’altro è un suo riecheggiamento in forma più blanda ed incerta (così diretta è l’auto-espressione del popolo che diventano irrilevanti sino adileguare del tutto gli organismi rappresentativi, le istituzioni statali e dunque,paradossalmente, la stessa democrazia). La contrapposizione della democrazia diretta a quella rappresentativa scaturisce comunque dal rifiuto di una «democrazia» che non riesce a dispiegare alcuna efficacia nei luoghi di produzione, nelle fabbriche, dove, secondo l’analisi del Manifesto del partito comunista, gli operai, «organizzati militarmente» e, «come soldati semplici dell’industria […] sottoposti alla sorveglianzadi tutta una gerarchia di sottufficiali e di ufficiali», continuano ad essere sottoposti ad un «dispotismo» che in pratica li priva di quella stessa libertà negativa che pure la tradizione liberale dice di avere a cuore. Per un altro verso, però, la contrapposizione in questione sembra scaturire dall’illusione che, col dileguare della mediazione costituita dalla rappresentanza, il popolo riuscirebbe a esprimere la sua carica autentica di emancipazione senza più ostacoli o distorsioni. E’ un’illusione ben si comprende a partire dai presupposti anche epistemologici dell’anarchismo che talvolta assume toni irrazionalistici, con Bakunin costantemente impegnato a celebrare l’«istinto» e la «vita» in contrapposizione al «pensiero» e alla sua pretesa di «prescrivere regole alla vita»: come violenza e sopraffazione si configura allora l’idea di rappresentanza in quanto tale, che al dirigente anarchico fa pensare a Saturno il quale «rappresentava i propri figli a misura che se li divorava». Ma questa fede in una spontaneità mitica, senza mediazioni e senza storia, ben difficilmente può essere conciliabile con la tesi di Marx secondo cui le idee dominanti sono le idee della classe dominante, quella che monopolizza i mezzi di produzione materiale e spirituale.
La rappresentanza diverrebbe superflua dopo il rovesciamento del potere politico ed economico della borghesia? Stato e rivoluzione cade nel momento in cui più aspra era, e non poteva non essere, la denuncia dei regimi rappresentativi liberali o liberal-democratici: nel corso della prima guerra mondiale, essi effettivamente funzionano nel modo descritto dal dirigente anarchico, dato che tranquillamente immolano milioni di uomini e di «rappresentati» in un gigantesco rito sacrificale. Eppure, persino in tale scritto possiamo leggere che anche la democrazia più sviluppata non può fare a menodi «istituzioni rappresentative». E tuttavia, il mito dell’estinzione dello Stato continuaad alimentare la diffidenza nei confronti dell’idea di rappresentanza nello stesso momento in cui la Russia scaturita dalla rivoluzione d’Ottobre vede moltiplicarsi i Soviet, organismi rappresentativi che non rifuggono neppure da una rappresentanza a più gradi. D’altro canto, a dirigere il nuovo Stato è un partito che, ben lungi dall’abbandonarsi al culto dell’immediatezza e della spontaneità, si organizza e siarticola mediante una complessa rete di mediazioni e di rappresentanza a più gradi.
Protagonista dell’esperienza dei Consigli fondati, come i Soviet, sul principio della rappresentanza e persino della rappresentanza a più gradi, Gramsci non attribuisce alcun rilievo al tema della democrazia diretta; forse, nei Quaderni è persino assente l’espressione. La cosa ben si si comprende. Se la società civile è una forma di Stato ed è essa stessa il luogo del potere e del dominio, demandare ad essa l’investitura diretta di un leader politico o di un gruppo dirigente non è affatto sinonimo di emancipazione. Gramsci è il pensatore marxista che fornisce gli strumenti teorici più adeguati per la lotta contro il bonapartismo soft, per la lotta cioè contro la riduzione della democraziaa investitura diretta e plebiscitaria di un leader più o meno carismatico e fornito di amplissimi poteri.
In conclusione, potremmo dire che in Marx e Engels, dopo aver giocato un ruolo fondamentale nella conquista del potere, la politica sembra poi dissolversi assieme allo Stato e al potere politico. Tanto più che, oltre alle classi, allo Stato e al potere politico, dileguano anche la divisione del lavoro, le nazioni, le religioni, il mercato, ogni possibile fonte di conflitto. Sostanzialmente immutata rimane questa piattaforma teorica in Lenin; epperò, in contraddizione con essa, abbiamo visto il dirigente bolscevico impegnarsi nella costruzione concreta del nuovo Stato e dei suoi organismi rappresentativi. Ma è solo con Gramsci che il messianismo comincia a cadere in crisi anche sul piano teorico: se risulta assai difficile o impossibile separare nettamente società civile e Stato, di una straordinaria vitalità si rivelano gli organismi nazionali (nella cui identità è spesso presente una forte componente religiosa); quanto poi al mercato, converrebbe parlare di «mercato determinato» piuttosto che di mercatoin quanto tale. Assistiamo allo sforzo di conferire un corpo politico ovvero un corpo politico più robusto al pensiero marxista. Emerge ora con nettezza il posto originale nell’ambito del marxismo novecentesco occupato da Gramsci. Questi agisce in una situazione relativamente privilegiata. L’Italia interviene più tardi nel primo conflitto mondiale, e questa ha un impatto catastrofico soprattutto in Russia e in Germania, dove particolarmente elevato è il numero delle vittime e dove alla guerra propriamente detta s’intrecciano la rivoluzione e una guerra civile esplicita o latente, un radicale mutamento di regime,una crisi economica, politica e ideale di carattere epocale. Tutto ciò favorisce la lettura in chiave apocalittica del marxismo, tanto più che ad alimentarla ulteriormente è il peso della grande intellettualità ebraica. La tradizione religiosa e culturale alle sue spalle per un verso stimola potentemente la ribellione contro la guerra e il massacro imperialista, per un altro verso tende a conferire a tale ribellione una valenza messianica. Il richiamo alla tradizione religiosa ebraica è talvolta esplicito e dichiarato. E’ il caso di Benjamin e, in modo più sfumato e mediato, anche di altri autori. Il giovane Bloch viene descritto da testimoni a lui contemporanei come «un nuovo filosofo ebreo» che si crede, «manifestamente, il precursore di un nuovo Messia». E, in effetti, fa pensare più ad Isaia che a Marx.
Spirito dell’utopia che, nella sua prima versione, chiama la Russia sovietica e il comunismo a realizzare la «trasformazione delpotere in amore». In Gramsci, invece, la rivoluzione comunista rappresenta certo un momento di rottura ma non è la negazione pura e semplice del passato e l’approdo ad un Novum trasfigurato dall’utopia. L’esperienza traumatica del macello consumatosi nel corso della prima guerra mondiale e del successivo avvento del fascismo stimola nel marxismo novecentesco un atteggiamento di liquidazione della storia della borghesia, anzi di tutta la storia passata, come un cumulo di errori e orrori. Contro tale «antistoricismo», sinonimo di «metafisica», polemizzano i Quaderni del carcere: non ha senso liquidare «il passato come “irrazionale” e “mostruoso”» riducendo così la storia politica e delle idee a un «trattato storico di teratologia», a una grottesca vicenda di mostri.
Prendere le distanze dal messianismo e dall’anarchismo e sforzarsi di conferire un corpo politico ovvero un corpo politico più robusto al marxismo significa anche rompere con la lettura in chiave economicistica di questa tradizione di pensiero. In Italia, il lorianesimo non solo riduceva il materiale all’economico, ma pretendeva di istituire una sorta di corrispondenza bi-univoca tra singolo fatto economico e singola espressione ideologica e politica. Ed è così che, nel confutarli, Max Weber legge Marx ed Engels. Il grande sociologo tedesco sembra avuto una certa stima di Achille Loria. E’ forse anche per questo che considera imprecisa l’espressione di «materialismo storico» e ritiene che si dovrebbe piuttosto parlare di «interpretazione economica delcorso storico» ovvero «della realtà». In modo analogo argomentano in Germania altri grandi intellettuali, come Scheler e Sombart. Da questa tipo di lettura prende le distanze già Lenin: «Ma dove avete “letto” in Marx e in Engels che essi parlassero necessariamente di materialismo economico? Quando essi definirono la loro concezione del mondo, la chiamarono semplicemente materialismo». Epperò, sia pur con qualche riserva, il Che fare? sembra accettare «la denominazione di “economismo” (alla quale non abbiamo nessuna intenzione dirinunziare poiché, in un modo o nell’altro, essa ha ormai ottenuto diritto dicittadinanza)». Se nel suo metodo di analisi concreta della situazione concreta ilrivoluzionario russo è generalmente ben lontano dall’economismo, sul piano teoricosembra rifuggire da una condanna netta e senza equivoci.
Diverso è il caso di Gramsci, alle cui spalle agisce la lezione di Croce. Questi richiama l’attenzione sul fatto che «le due formule» di «concezione economica della storia» e di «materialismo storico» non sono «sinonimiche». Dopo aver fatto risalire a Loria la stessa espressione di «economismo storico» (caratterizzato come un insieme di«concezioni più o meno sgangherate»), i Quaderni del carcere sottolineano: «Avviene spesso che si combatta l’economismo storico, credendo di combattere il materialismo storico». Ma Gramsci procede oltre. Non solo distingue nettamente la visione del processo storico propria di Marx e Engels dalle sue interpretazioni o contraffazioni in chiave economicistica, ma, sia pur timidamente, critica i residui di economicismo e meccanicismo presenti in quella stessa visione. Nei testi dei due fondatori del materialismo storico è possibile sorprendere due diverse e contrastanti versioni della teoria della rivoluzione, anche se il punto di partenza è pur sempre costituito dall’acutizzarsi della contraddizione tra forze produttive e rapporti di produzione. Grevemente meccanicistica è la versione consegnata alla celeberrima pagina del Capitale che vede la rivoluzione socialista come conseguenza immediata e automatica del compiersi del processo di accumulazione capitalistica che avanza implacabilmente espropriando i piccoli produttori sino al momento in cui «suona l’ultima ora dellaproprietà privata capitalistica» e «gli espropriatori vengono espropriati». La politica, le peculiarità nazionali, i fattori ideologici, la stessa coscienza rivoluzionaria, tutto ciò sembra non giocare alcun ruolo, ed è chiaro che tale teoria è inservibile per spiegare una qualsiasi rivoluzione concretamente determinata. Al contrario, il Manifesto del partito comunista prevede la possibilità di una rivoluzione socialista in un paese come la Germania che, sul piano dello sviluppo capitalistico è ancora piuttosto arretrato rispetto all’Inghilterra e che, per quanto riguarda l’assetto propriamente politico, è al di qua della rivoluzione borghese. In Gramsci non c’è traccia della prima versione, quella economicistica, della rivoluzione. Questa scaturisce da una molteplicità e un intreccio di contraddizioni diverse. Per usare il linguaggio di Althusser, potremmo dire che la rottura rivoluzionaria è per definizione sovradeterminata: essa presenta un’ineludibile dimensione nazionale, e dunque si colloca in un contesto storico e culturale determinato e con caratteristiche peculiari. Considerazioni analoghe potrebbero ovviamente essere fatte valere anche per Lenin, ma è solo Gramsci a spingersi sino alla critica di Marx e Engels. Il celebre articolo che saluta la rivoluzione d’Ottobre scoppiata «contro Il capitale» (positivisticamente interpretato dalla Seconda Internazionale) sottolinea che da «incrostazioni positivistiche e naturalistiche» (ed economicistiche) non sono immuni neppure nei fondatori del materialismo storico. E’ in questo contesto che va collocata l’attenzione tutta particolare rivolta al tema dell’egemonia. Per comprendere adeguatamente questo punto, non ci si può limitare alla dicotomia egemonia/dittatura ovvero consenso/coercizione. Gramsci sottolinea ripetutamente che ogni Stato comporta entrambi i momenti, anche se il secondo, ne ipaesi di consolidata tradizione liberale, diviene evidente soprattutto in situazioni di crisi acuta; peraltro, questi due momenti sono presenti all’interno della stessa società civile. Se anche progetta un ordinamento in cui sia ridotto al minimo il momento della coercizione, il teorico dell’egemonia non è il profeta disarmato o l’anima bella che evade dal terreno delle contraddizioni reali. Il tema dell’egemonia istituisce in primo luogo una polemica contro ogni visione meccanicistica ed economicistica della storia,del processo rivoluzionario e dello stesso processo di formazione della coscienza rivoluzionaria. Il Manifesto del partito comunista insiste sul fatto che l’organizzazione del proletariato in classe è continuamente rimessa in discussione dalla concorrenza economica che il capitale suscita tra i membri della classe operaia. Senza ignorare questo aspetto, Gramsci richiama l’attenzione sugli aspetti politici e persino morali del passaggio dalla classe in sé alla classe per sé. Per conquistare autonoma soggettività politica, le classi subalterne devono saper realizzare una «riforma intellettuale e morale», devono riuscire a distaccarsi dall’arroccamento corporativo e saper procedere ad una «catarsi» culturale e politica (emergono qui una problematica e una terminologia che rompono definitivamente con l’interpretazione in chiave economicistica del materialismo storico):
«Il metallurgico, il falegname, l’edile, ecc. devono non solo pensare come proletari e non più come metallurgico, falegname, edile, ecc., ma devono fare ancora un passo avanti; devono pensare come operai membri di una classe che tende a dirigere i contadini e gli intellettuali, di una classe che può vincere e può costruire il socialismo solo se aiutata e seguita dalla grande maggioranza di questi strati sociali. Se non si ottiene ciò, il proletariato non diventa classe dirigente».
Tutta una tradizione di pensiero, liberale o reazionaria, pretende di individuare nell’invidia o nel ressentiment la molla del socialismo: così Nietzsche e così in Italia, per fare solo un esempio, Pareto. La riflessione di Gramsci in carcere si sviluppa mentre in Germania il nazismo attizza il risentimento e l’invidia degli strati popolari più arretrati nei confronti degli intellettuali soprattutto rivoluzionari e incanala contro gli ebrei la frustrazione delle masse impoverite dalla guerra e dalla crisi economica. Contrariamente al luogo comune della tradizione di pensiero liberale o reazionaria, il ressentiment si rivela uno strumento della reazione per deviare su falsi bersagli la protesta sociale, per frantumare le classi subalterne in innumerevoli rivoli corporativi e spezzare e liquidare il movimento operaio e comunista. Alla luce di tutto ciò, acquista particolare rilievo la riflessione dei Quaderni che, significativamente, individuano nel «momento “catartico” […] il punto di partenza per tutta la filosofia della prassi».
Con Gramsci siamo in presenza di un autore e di un dirigente politico che ha vissuto la tragedia della sconfitta del movimento operaio e della vittoria del fascismo e, proprio per questo, è stato costretto a rompere con le speranze di rapida e definitiva palingenesi rivoluzionaria, per approfondire invece l’analisi del carattere complesso e contraddittorio del processo di trasformazione politica e sociale. Per quanto riguarda la Francia, il ciclo della rivoluzione borghese abbraccia un periodo che va dal 1789 al 1871; il passaggio dal capitalismo alla «società regolata», cioè al comunismo, «durerà probabilmente dei secoli». Tale approccio teorico non può non risultare particolarmente stimolante e fecondo in un momento storico come quello attuale, in cui il movimento di emancipazione delle classi e dei popoli in condizione subalterna è costretto a registrare una nuova e disastrosa sconfitta. Non si tratta di un motivo consolatorio.
Ricapitoliamo il cammino sin qui percorso. Gramsci richiama l’attenzione sulle ampie possibilità che si offrono alla classe dominante di decapitare politicamente e ideologicamente le classi subalterne; con la sua fenomenologia del potere individua il luogo del dominio non solo nello Stato politico propriamente dettoma nella stessa società civile; insiste sulla dimensione non solo economica e politica,ma anche ideologica e persino morale del processo di formazione della coscienza rivoluzionaria. Per tutte queste ragioni, Gramsci non solo è assai lontano da ogni teoria del crollo ma sviluppa una visione della storia basata sulla complessità del processo di trasformazione, sui tempi lunghi del passaggio dall’antico regime all’«ordine nuovo». Questo stesso «ordine nuovo» comincia ad essere pensato con un approccio più realistico rispetto alla tradizione che prende le mosse da Marx. Questi, nella Miseria della filosofia, rimprovera agli economisti borghesi di essere attaccati ad una visione per cui «c’è stata storia, ma ormai non ce n’è più». Paradossalmente, tale visione ha finito con l’essere ereditata dal «socialismo reale»; dopo il brusco risveglio ai suoi ideologi imposto dalla storia, la parola d’ordine della «fine della storia» è ritornata agli apologeti della società borghese. Criticare quest’ultima, confutare gli ingenui ideologi della sua eternità e intranscendibilità non significa riprendere acriticamente,come se nulla fosse successo, utopie astratte. Heri dicebamus: questo può essere l’atteggiamento degli idealisti pronti a ridurre la concreta vicenda storica ad una sorta parentesi che può essere tranquillamente ignorata, non già di coloro che fanno professione di materialismo storico. Con la sua, sia pur timida, presa di distanza da ogni visione anarchica e più o meno apocalittica della trasformazione politico-sociale, Gramsci ha indicato una via che dev’essere ancora percorsa sino in fondo: pensare un incisivo progetto di emancipazione che non pretenda di essere la fine della storia. Si tratta di prendere congedo da utopie astratte, spiegando al tempo stesso le ragioni storiche del loro emergere. Possiamo qui far tesoro di un’indicazione di Engels, il quale, nel fare il bilancio della rivoluzione inglese e francese, osserva: «Affinché potessero venire assicurate almeno quelle conquiste della borghesia che erano mature e pronte adessere mietute, era necessario che la rivoluzione oltrepassasse il suo scopo […] Sembra che questa sia una delle leggi dell’evoluzione della società borghese». Non c’è motivo per sottrarre alla metodologia materialistica elaborata da Marx e Engels il movimento storico reale e la rivoluzione che a loro si sono ispirati. In fondo, ogni rivoluzione tende a presentarsi come l’ultima, anzi come la soluzione di ogni contraddizione e quindi come la fine della storia.
L’incisivo progetto di emancipazione che non pretenda di essere la fine della storia e di ogni conflitto dev’essere pensato in una situazione radicalmente diversa rispetto al passato, il quale tuttavia non può essere sommariamente liquidato. Nonostante gli orrori della prima guerra mondiale e del fascismo, abbiamo visto i Quaderni del carcere rifiutarsi di leggere la storia moderna come un trattato di «teratologia»; non c’è motivo di leggere in questo modo la storia del «socialismo reale», nonostante gli errori, le colossali mistificazioni e gli orrori che l’attraversano. L’autore che ha chiamato il movimento operaio e comunista ad ereditare i punti alti della rivoluzione francese può ben essere d’aiuto oggi a comprendere il problema dell’eredità anche per quanto riguarda la rivoluzione d’Ottobre”.


