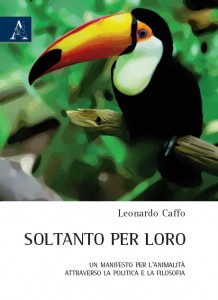Contro una filosofia fondata sul diritto alla vita, all’espressione e … alla morte dei viventi. «Soltanto per loro» di Leonardo Caffo (qui il link per uno sconto Amazon del testo
Contro una filosofia fondata sul diritto alla vita, all’espressione e … alla morte dei viventi. «Soltanto per loro» di Leonardo Caffo (qui il link per uno sconto Amazon del testo ), «Ai confini dell’umano» di Massimo Filippi (qui il link per uno sconto Amazon del testo
), «Ai confini dell’umano» di Massimo Filippi (qui il link per uno sconto Amazon del testo ) e i saggi di «Nell‘Albergo di Adamo» (qui il link per ordinare il libro con uno sconto Amazon
) e i saggi di «Nell‘Albergo di Adamo» (qui il link per ordinare il libro con uno sconto Amazon )
)
— — —
Il problema dell’animalismo è che la questione dell’animalità, in realtà, non riguarda gli animali. O meglio, non riguarda solo gli animali (non umani). In effetti il limite di molto animalismo è quello di credere che ci si possa occupare del benessere animale senza occuparsi anche di quello degli animali umani. C’è un’unica logica che lega gli orrori del mattatoio con quelli dello sfruttamento dei lavoratori, dell’espropriazione dei beni comuni, della trasformazione della stessa vita umana in merce.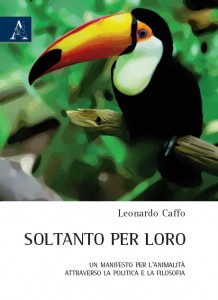 Per questo, come scrive Leonardo Caffo in Soltanto per loro. Un manifesto per l’animalità attraverso la politica e la filosofia (Aracne, pp. 136, euro 9), «dev’essere chiaro fin da subito che essere animalisti, in senso forte, significa fare una scelta politica». L’animalismo o sta dalla parte di un radicale cambiamento dell’assetto sociale esistente, oppure si condanna da solo all’irrilevanza. Finché l’unica logica ammessa è quella della valorizzazione del capitale, non sarà possibile salvare la pelle né di una mucca né di un minatore. Il problema non è quello di preoccuparsi di far morire in modo non troppo cruento un maiale (anche se è un problema urgente e importante), piuttosto quello di provare a immaginare un’organizzazione sociale non basata sullo sfruttamento e l’espropriazione della vita: «ciò che sembra necessario è rendere collettiva una scelta non violenta ma non lo si può fare sperando, ‘semplicemente’, che un giorno i supermercati sostituiscano al bancone di carne e formaggio rispettivamente quelli di seitan e tofu. Ciò che sembra necessario è mettere in discussione la struttura stessa del supermercato e dei sistemi affini che forniscono una presunta libertà di scegliere fra ciò che è già stato scelto a monte». Per salvare il pollo occorre capire come funziona l’economia politica, prima ancora che provare a stabilire se un pollo ha o no una vita mentale. Anche perché, è ancora Caffo a metterci in guardia, altrimenti è forte il rischio di cadere nell’antropomorfismo, un rischio in cui anche molti animalisti continuano a cadere. È, per esempio, uno strano modo di amare gli animali quello di chi dice del proprio cane (quale stranezza, essere padroni di una vita) che gli manca solo la parola: cioè che quel cane è da amare non perché è un cane, bensì perché è quasi un uomo.
Per questo, come scrive Leonardo Caffo in Soltanto per loro. Un manifesto per l’animalità attraverso la politica e la filosofia (Aracne, pp. 136, euro 9), «dev’essere chiaro fin da subito che essere animalisti, in senso forte, significa fare una scelta politica». L’animalismo o sta dalla parte di un radicale cambiamento dell’assetto sociale esistente, oppure si condanna da solo all’irrilevanza. Finché l’unica logica ammessa è quella della valorizzazione del capitale, non sarà possibile salvare la pelle né di una mucca né di un minatore. Il problema non è quello di preoccuparsi di far morire in modo non troppo cruento un maiale (anche se è un problema urgente e importante), piuttosto quello di provare a immaginare un’organizzazione sociale non basata sullo sfruttamento e l’espropriazione della vita: «ciò che sembra necessario è rendere collettiva una scelta non violenta ma non lo si può fare sperando, ‘semplicemente’, che un giorno i supermercati sostituiscano al bancone di carne e formaggio rispettivamente quelli di seitan e tofu. Ciò che sembra necessario è mettere in discussione la struttura stessa del supermercato e dei sistemi affini che forniscono una presunta libertà di scegliere fra ciò che è già stato scelto a monte». Per salvare il pollo occorre capire come funziona l’economia politica, prima ancora che provare a stabilire se un pollo ha o no una vita mentale. Anche perché, è ancora Caffo a metterci in guardia, altrimenti è forte il rischio di cadere nell’antropomorfismo, un rischio in cui anche molti animalisti continuano a cadere. È, per esempio, uno strano modo di amare gli animali quello di chi dice del proprio cane (quale stranezza, essere padroni di una vita) che gli manca solo la parola: cioè che quel cane è da amare non perché è un cane, bensì perché è quasi un uomo.
La questione dell’animalismo è pertanto quella di una politica e di una filosofia che pongano al centro dell’attenzione il «diritto alla vita, all’espressione, alla morte» dei viventi. A partire, come ci ricorda Darwin, dalla infinita diversità delle forme di vita. Qui è da segnalare il libro di Massimo Filippi, Ai confini dell’umano. Gli animali e la morte (ombre corte, pp. 95, euro 10), che affronta il tema della «macchina antropologica», cioè dell’operazione mediante la quale la filosofia (come la religione) ribadisce la separatezza dell’umano rispetto all’animale. Una separatezza che arriva, con Heidegger, a sostenere che gli animali, in realtà, non muoiono, perché possono solo decedere, mentre la morte è una prerogativa esclusivamente umana. Ma che significa che gli animali non muoiono? Che l’umano è comunque qualcosa di radicalmente diverso dal resto dei viventi. Ora, già nell’assurdità stessa di parlare dell’animale al singolare, dell’animalità in generale, è implicita una separatezza che tanto più è falsa tanto più sempre di nuovo deve essere ribadita. Filippi ricostruisce l’apparato concettuale che permette questa operazione, non per mostrare che l’umano non è altro che un animale (mossa speculare a quella dello specismo separatista), ma per mettere l’umano fra gli altri animali. E mette in evidenza il paradosso dell’antispecismo, che nella fretta di parificare l’animale all’umano continua a «ignorare il verso dell’animale, la cui morte ha reso possibile il diritto dell’uomo». Non si possono difendere i diritti animali a partire da quelli umani, dato che questi esistono solo in quanto basati sull’esclusione dell’animalità (l’uomo è ciò che non è animale). Una base comune per ripensare la questione animale può essere, allora, proprio quella della mortalità che accomuna i viventi: «questa ‘possibilità dell’impossibilità’ accomuna umani e animali non perché essi muoiono allo stesso modo (che cosa può significare una frase del genere?), ma perché entrambi com-patiscono, sostano pazienti in un’esposizione senza garanzie». A dispetto di Heidegger muoiono umani e virus, e tutti gli altri viventi. Non c’è un unico modo di vivere, come non c’è un solo modo di morire: «passare il confine della morte significa passare il confine tra noi e l’animale, distendere le maglie del ‘paradigma confine’ fino a trasgredirlo, fino a violarne la natura di proprietà privata, trasformandolo in territorio».
Qui è da segnalare il libro di Massimo Filippi, Ai confini dell’umano. Gli animali e la morte (ombre corte, pp. 95, euro 10), che affronta il tema della «macchina antropologica», cioè dell’operazione mediante la quale la filosofia (come la religione) ribadisce la separatezza dell’umano rispetto all’animale. Una separatezza che arriva, con Heidegger, a sostenere che gli animali, in realtà, non muoiono, perché possono solo decedere, mentre la morte è una prerogativa esclusivamente umana. Ma che significa che gli animali non muoiono? Che l’umano è comunque qualcosa di radicalmente diverso dal resto dei viventi. Ora, già nell’assurdità stessa di parlare dell’animale al singolare, dell’animalità in generale, è implicita una separatezza che tanto più è falsa tanto più sempre di nuovo deve essere ribadita. Filippi ricostruisce l’apparato concettuale che permette questa operazione, non per mostrare che l’umano non è altro che un animale (mossa speculare a quella dello specismo separatista), ma per mettere l’umano fra gli altri animali. E mette in evidenza il paradosso dell’antispecismo, che nella fretta di parificare l’animale all’umano continua a «ignorare il verso dell’animale, la cui morte ha reso possibile il diritto dell’uomo». Non si possono difendere i diritti animali a partire da quelli umani, dato che questi esistono solo in quanto basati sull’esclusione dell’animalità (l’uomo è ciò che non è animale). Una base comune per ripensare la questione animale può essere, allora, proprio quella della mortalità che accomuna i viventi: «questa ‘possibilità dell’impossibilità’ accomuna umani e animali non perché essi muoiono allo stesso modo (che cosa può significare una frase del genere?), ma perché entrambi com-patiscono, sostano pazienti in un’esposizione senza garanzie». A dispetto di Heidegger muoiono umani e virus, e tutti gli altri viventi. Non c’è un unico modo di vivere, come non c’è un solo modo di morire: «passare il confine della morte significa passare il confine tra noi e l’animale, distendere le maglie del ‘paradigma confine’ fino a trasgredirlo, fino a violarne la natura di proprietà privata, trasformandolo in territorio».
E così di nuovo torniamo al tema politico dell’animalità, quello di una vita non mercificata. Al centro di questo progetto c’è, di nuovo e ancora, il corpo, che «è l’eminentemente vulnerabile che condividiamo con tutto il vivente»; quel vivente che «è proprio l’accettazione di tale vulnerabilità che pervade l’esperienza affettiva, potenzialmente compassionevole, ospitante e cordiale verso gli altri corpi». La questione dell’animalità, pertanto, «costituisce l’impensato della nostra civilizzazione», come scrivono Massimo Filippi e Filippo Trasatti nell’introduzione alla raccolta di saggi Nell’albergo di Adamo. Gli animali, la questione animale e la filosofia (Mimesis, pp. 317, euro 22): lo sfruttamento dell’animale è il paradigma e il modello di quello umano (al proposito si rilegga il tremendo libro di Charles Patterson, Un’eterna Treblinka. Il massacro degli animali e l’Olocausto, Editori Riuniti, in cui si mostra come la burocrazia nazista si ispirò ai mattatoi per organizzare lo sterminio di milioni di esseri umani). Fra i numerosi e interessanti saggi di questo libro, che si può leggere come prima approssimazione a quegli animal studies ancora poco noti in Italia, segnaliamo quello di Marco Maurizi, che affronta il difficile tema del rapporto fra marxismo e mondo della natura. Che posto assegnare, agli animali, in una società senza classi? «L’animale, sia esso ridotto a merce o asservito come mezzo di produzione, è un ingranaggio della società di classe che aspetta, come altri, la propria ridefinizione in una società socialista». La liberazione dell’animale non potrà avvenire senza una parallela liberazione dell’umano, «perché ciò che di essenziale la sua domesticazione ha prodotto per noi non è la carne di manzo o l’avorio, ma il dominio che attraverso questi si esercita sull’uomo. L’assoggettamento dell’animale non rientra nella storia della libertà dell’uomo ma in quella della sua stessa schiavitù».
La questione dell’animalità, pertanto, «costituisce l’impensato della nostra civilizzazione», come scrivono Massimo Filippi e Filippo Trasatti nell’introduzione alla raccolta di saggi Nell’albergo di Adamo. Gli animali, la questione animale e la filosofia (Mimesis, pp. 317, euro 22): lo sfruttamento dell’animale è il paradigma e il modello di quello umano (al proposito si rilegga il tremendo libro di Charles Patterson, Un’eterna Treblinka. Il massacro degli animali e l’Olocausto, Editori Riuniti, in cui si mostra come la burocrazia nazista si ispirò ai mattatoi per organizzare lo sterminio di milioni di esseri umani). Fra i numerosi e interessanti saggi di questo libro, che si può leggere come prima approssimazione a quegli animal studies ancora poco noti in Italia, segnaliamo quello di Marco Maurizi, che affronta il difficile tema del rapporto fra marxismo e mondo della natura. Che posto assegnare, agli animali, in una società senza classi? «L’animale, sia esso ridotto a merce o asservito come mezzo di produzione, è un ingranaggio della società di classe che aspetta, come altri, la propria ridefinizione in una società socialista». La liberazione dell’animale non potrà avvenire senza una parallela liberazione dell’umano, «perché ciò che di essenziale la sua domesticazione ha prodotto per noi non è la carne di manzo o l’avorio, ma il dominio che attraverso questi si esercita sull’uomo. L’assoggettamento dell’animale non rientra nella storia della libertà dell’uomo ma in quella della sua stessa schiavitù».
(Articolo di Felice Cimatti “Quella falsa separatezza fra la nostra e le altre specie” tratto da Il Manifesto)

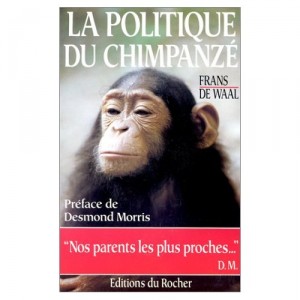




 Scrivere solo oggi un commento a “Roma combattente” e “Bastardi senza Storia” di Valerio Gentili (edizioni Castelvecchi) potrebbe sembrare superfluo perchè, almeno il primo libro, è in commercio dal lontano aprile del 2010 ed a distanza di due anni e mezzo non è scontato che un testo continui a mantenere una certa potenza creativa conservando uguale capacità di analisi. Anche solo per il fatto che le situazioni possano cambiare enormemente. In realtà è proprio in questo momento che l’operazione storiografica promossa dall’autore ci sembra assumere maggiore evidenza. Il deflusso della stagione “no global” (o “new global”, “alter global” e via dicendo come dir si voglia) e la ripresa di un ciclo di conflittualità dalla fine del 2010 fino ad oggi racconta una storia dell’antagonismo estremamente frastagliata e composita. Non solo a livello nazionale ma in tutto il mondo. Naturalmente tra ieri (il periodo preso in considerazione dal libro, dal
Scrivere solo oggi un commento a “Roma combattente” e “Bastardi senza Storia” di Valerio Gentili (edizioni Castelvecchi) potrebbe sembrare superfluo perchè, almeno il primo libro, è in commercio dal lontano aprile del 2010 ed a distanza di due anni e mezzo non è scontato che un testo continui a mantenere una certa potenza creativa conservando uguale capacità di analisi. Anche solo per il fatto che le situazioni possano cambiare enormemente. In realtà è proprio in questo momento che l’operazione storiografica promossa dall’autore ci sembra assumere maggiore evidenza. Il deflusso della stagione “no global” (o “new global”, “alter global” e via dicendo come dir si voglia) e la ripresa di un ciclo di conflittualità dalla fine del 2010 fino ad oggi racconta una storia dell’antagonismo estremamente frastagliata e composita. Non solo a livello nazionale ma in tutto il mondo. Naturalmente tra ieri (il periodo preso in considerazione dal libro, dal  Dopo la trilogia è arrivato anche il (non) Manifesto e si presenta un po’ come i titoli di coda di un lavoro lungo circa un decennio. È questo il percorso del ticket Hardt & Negri, che ancora continua a snocciolare teoria per allietare le prospettive del movimento ed estenderne le capacità di conflitto e di organizzazione. Già in “
Dopo la trilogia è arrivato anche il (non) Manifesto e si presenta un po’ come i titoli di coda di un lavoro lungo circa un decennio. È questo il percorso del ticket Hardt & Negri, che ancora continua a snocciolare teoria per allietare le prospettive del movimento ed estenderne le capacità di conflitto e di organizzazione. Già in “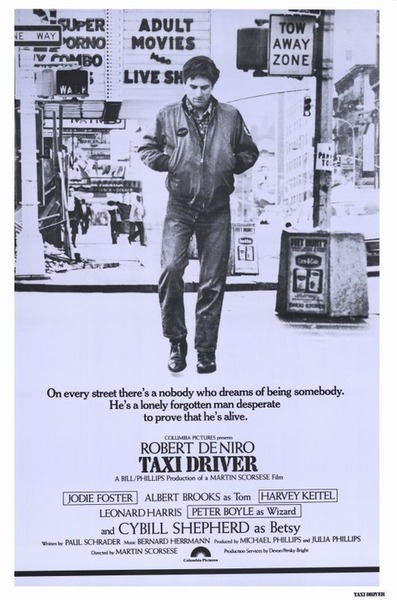


 Contro una filosofia fondata sul diritto alla vita, all’espressione e … alla morte dei viventi. «Soltanto per loro» di Leonardo Caffo (
Contro una filosofia fondata sul diritto alla vita, all’espressione e … alla morte dei viventi. «Soltanto per loro» di Leonardo Caffo (