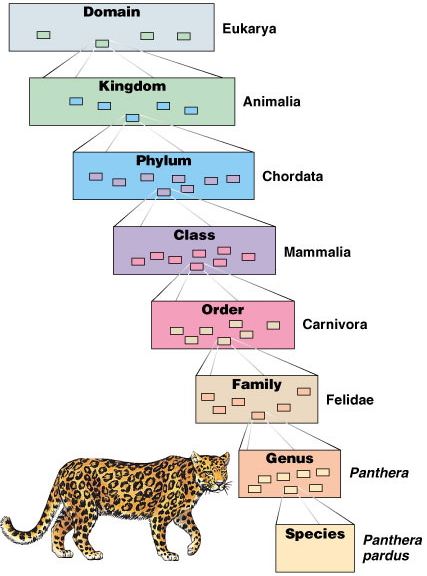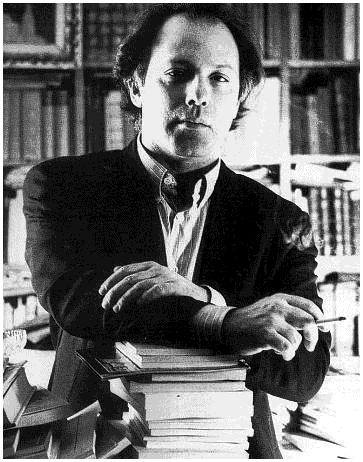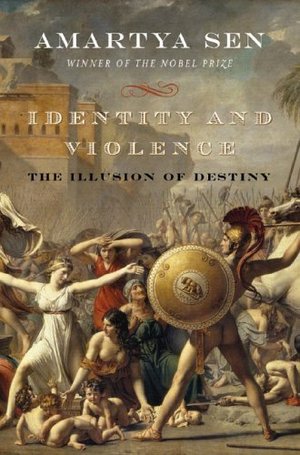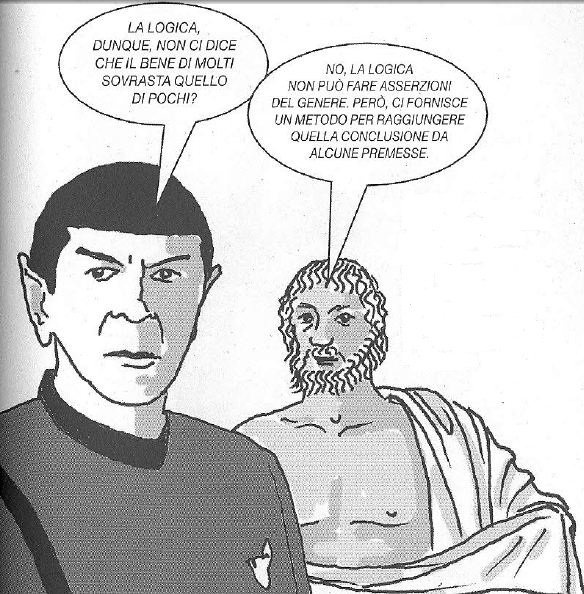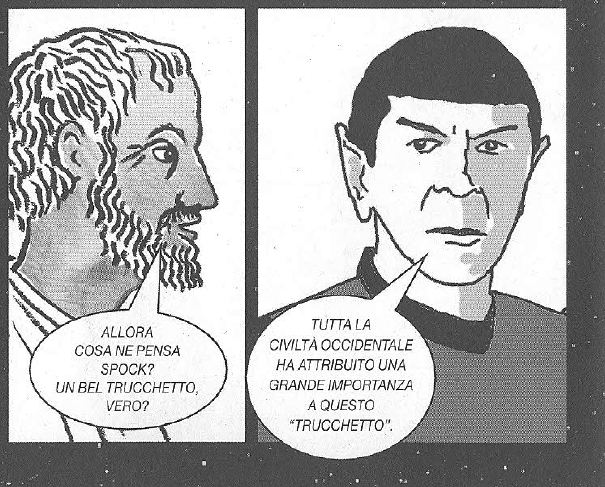Se ordini il libro tramite il nostro link hai diritto ad uno sconto significativo (Amazon): Vite che non possiamo permetterci. Conversazioni con Citlali Rovirosa-Madrazo
— — —
“[…] il recente tsunami finanziario […] ha dimostrato a milioni di individui, cullati nel miraggio della prosperità ora e sempre e convinti che i mercati capitalistici e le banche fossero i metodi garantiti per risolvere i problemi, che il capitalismo dà il meglio di sé non quando cerca di risolvere i problemi ma quando li crea”
“Vite che non possiamo permetterci” è il frutto delle conversazioni avute dal sociologo con il giornalista-docente Citali Bovirosa-Madrazo sul significato, le cause, le implicazioni morali e non morali della prima crisi finanziaria globale del secolo. Il titolo originale del testo (“Living on Borrowed Time” – letteralmente “vivendo in un tempo preso in prestito”) esplicita come l’uomo contemporaneo, nella sua età matura, dove il tempo speso non tornerà più, sia avvezzo a prendere in prestito il tempo, allo stesso modo con cui prende in prestito il denaro per vivere questo tempo. A gioire di questa costante attitudine al debito sono le banche: “le banche che amano dire di si. Le tue banche amiche, Banche che sorridono […]” Uno dei successi più grandi del capitalismo è infatti quello di aver trasformato uomini e donne in un popolo di eterni debitori: “il segnale è stato l’introduzione delle carte di credito […] con lo slogan take the waiting out of wanting “ togli l’attesa del desiderio”[…] con una carta di credito si può godersela adesso e pagare dopo. La carta di credito ci rende liberi di gestire le gratificazioni, di ottenere le cose quando vogliamo non quando ce le saremo guadagnate e potremo quindi permettercele. Questa era la premessa ma vi era allegata una clausola[…]: ogni dopo diventerà un adesso, i prestiti dovranno essere rimborsati e il rimborso dei debiti contratti per eliminare l’attesa dal desiderio e soddisfare immediatamente i desideri attuali renderà ancora più difficile soddisfare i nuovi desideri”.
L’odierna crisi è, infatti, frutto non del fallimento delle banche ma del loro grande successo “perché l’unico modo ad oggi conosciuto per estinguere un debito è quello di rendere i soldi che si sono avuti in prestito, giusto? E a chi chiederemo altri soldi, per poterci indebitare ancor di più nel tentativo di ripianare il primo debito, se non alle banche?”.
Secondo il sociologo l’attuale crisi finanziaria può, però, rappresentare un’occasione per riflettere sulla attuale situazione mondiale, per analizzarla e creare “nuova conoscenza” ed una revisione del modello economico fino ad oggi seguito ed approvato dagli Stati: “Nel capitalismo la collaborazione tra Stato e mercato è la regola, e il conflitto, se mai affiora, è l’eccezione”.
L’autore affronta poi anche alcune tematiche che alla questione della crisi finanziaria sono intimamente connesse come lo stato delle democrazie, il welfare, i fondamentalismi, le biotecnologie e la modernità; il tutto letto alla luce del concetto di liquidità che rappresenta il filo rosso con cui Bauman interpreta i cambiamenti e le trasformazioni della società contemporanea. Qualche parola in più merita il capitolo sui cambiamenti dello Stato Sociale che, se nella società dei produttori era di casa, nella società dei consumatori è diventato “un corpo estraneo e un ospite inopportuno”. Il welfare oggi è, infatti, secondo l’autore, esclusivamente “un’agenzia che serve a censire, separare ed escludere” gli individui incapaci di provvedere economicamente a se stessi, separandoli dalla parte “normale” della società e rinchiudendoli in “un ghetto senza mura” o “un campo senza filo spinato”. La tendenza odierna porta quindi lo Stato ad abbandonare uomini e donne alla povertà, al degrado e all’esclusione sociale dimenticando che:
“la società può elevarsi a comunità solo finchè protegge efficacemente i suoi membri contro gli orrori gemelli della miseria e dell’umiliazione, del terrore di essere esclusi, di cadere, o essere spinti fuori dal treno del progresso, che accelera sempre più, di essere condannati alla ridondanza sociale o comunque marchiati come rifiuti umani”.