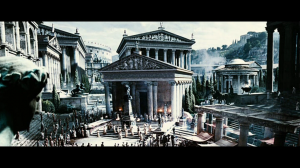Se ordini il libro di Mario Praz tramite il nostro link usufruisci di uno sconto significativo: La carne, la morte e il diavolo nella letteratura romantica (Alta fedeltà)
— — —
La ormai classica novità di La carne, la morte e il diavolo nella letteratura romantica di Mario Praz (BUR 2009²), pubblicato la prima volta nel 1930, consiste innanzi tutto nel fatto che il libro ripercorre tre letterature, inglese francese e italiana, isolando la sensibilità erotica degli autori romantici, in aperta sfida alla critica idealistica del tempo, e provocando la moralistica stroncatura di Benedetto Croce, che pretendeva una maggiore complessità per il romanticismo e per la vita stessa in cui non doveva prevalere «la patologia sessuale» e che «vuole la distinzione e con ciò l’armonia di tutte le sue parti». Tant’è vero che viene a un certo punto fatto di domandarsi, rileggendo Praz (e questa non è che una delle tante fascinazioni di questo testo, di segno spesso esoterico), quando, e addirittura se, sia davvero finito il Novecento (romantico), dal momento che, in secondo luogo, la più grande e seducente intuizione critica di Praz è stata quella di rimettere radicalmente in discussione le formule storiografiche ricorrenti, dandoci come un unicum indivisibile sia il romanticismo (e non solo le sue propagginazioni più abitualmente riconosciute come tali) sia la scapigliatura sia il verismo sia lo stesso decadentismo, prolungando il periodo romantico come un tutt’uno fino a gran parte della letteratura dello stesso Novecento, o almeno di quello a lui contemporaneo (Praz è morto nel 1982). Secondo Croce, era illegittimo da parte di Praz segnare in modo tanto debole la differenza tra romanticismo e decadentismo, e spingersi a «far consistere il cosiddetto romanticismo nella formazione di una sensibilità nuova, quella appunto che si manifesta nelle tendenze e figurazioni che egli così largamente espone». Nell’Avvertenza alla seconda edizione del 1942 Praz gli risponderà in modo articolato, peraltro basandosi proprio sulla crociana Storia d’Europa nel secolo decimonono, che la sua non è una sintesi del romanticismo tout courtbensì una monografia su particolarità tematiche della sensibilità romantica.
«L’epiteto romantico e l’antitesi classico-romantico sono approssimazioni da lungo tempo entrate nell’uso. Il filosofo le mette solennemente alla porta esorcizzandole con logica che non erra, ed esse rientrano chete chete per la finestra, e son sempre lì tra i piedi, elusive, assillanti, indispensabili.» Comincia così la monografia comparatistica di Praz, e subito segue l’osservazione che critica letteraria presuppone storia della cultura: «storia della cultura d’un ambiente e storia della cultura d’un individuo». Si continua per più di quattrocento pagine fittissime, infarcite di autori, personaggi, citazioni in francese, generi letterari, epoche, ambienti, miti, passioni, ripercorrendo le costanti tematiche della bellezza medusea cantata da Shelley, della metamorfosi diabolica in Byron, di Sade antecedente diretto dei romanzi di Flaubert, della bellezza diabolica celebrata da Keats, della Salomè di Wilde, dell’algolagnia sadomasochistica di Swinburne, dei plagi di D’Annunzio, messe in relazione con le innumerevoli varianti offerte dal contesto di volta in volta analizzato. Un gioco a incastri, aperture, intagli, passaggi sotterranei di cui è impossibile dare un resoconto esaustivo.
Di epicurei dall’immaginazione cattolica risulta piena la grande letteratura decadente a partire da Chateaubriand. Huysmans va d’accordo col marchese de Sade cogliendo una verità da trasgredire proprio in quanto creduta (diversamente non ci sarebbe nulla da violare). C’è il sospetto che Praz tratti la nevrosi di questi autori come un appianamento (o un sollievo) nella delectatio morosa, con un inevitabile residuo di irrisolto nella vita. A questo irrisolto lui sembra aderire perfettamente, perché è anche il suo, e resta il suo quando lo contesta o contestualizza in un’infinità di rimandi, giustamente proiettivi o esclusivi, coinvolgendo i generi minori e le arti figurative, soprattutto la pittura preraffaellita. In altri termini un cristianesimo torbido era già presente in Dostoevskij, investendo l’irrealtà quale giustificazione e soddisfacimento della pulsione: il peccato in convento o rivolgersi alla messa dopo la compulsione sessuale equivale sul piano filosofico ad assumere il sacro come profondità del profano e non come sua necessaria contraddizione. Huysmans predilige il latino post-classico perché si ritrova nella mancanza di equilibrio senecana e nel compiacimento di Petronio, molto più che nel tentativo del periodo cristiano di costringere a una mediazione il paganesimo e la nuova religione. Gide riceve una sostanziale stroncatura, eternamente oscillante tra la paura di compromettersi – a differenza di Wilde, che sfidò quella paura ribaltandola nella provocazione, fino a uno stupido errore di calcolo masochista (l’algolagnia) – e il desiderio di compromettersi. Gide è visto da Praz come un «ermafrodito morale, sospeso tra diverse possibilità e, in conclusione, negativo, sterile.» Ciò che dispiace di questo libro è semmai la considerazione in cui l’autore mostra di tenere Sainte-Beuve (già nell’Avvertenza del ’42, o per i rapporti tra Byron e Chateaubriand, per es., e comunque non sempre portato a modello), che, come è risaputo, non comprese Stendhal.

Quando si parla di Praz non si può non pensare alla sua casa. L’abitazione privata di Praz, oggi museo, era l’oggettivazione dell’io di Mario Praz, come se fosse una casa della morte. Non l’io sperimentale, anagrafico o pratico, bensì un io profondo, che stava al di qua degli oggetti – la sua collezione di arti minori – e al di là anche del suo caro e semplice io. Quella mancanza di vita, in un rispecchiamento dell’io sublime che si riconosceva negli oggetti raccolti nella casa-museo di Praz, era una contemplazione della morte sottoforma di vita, restituita dalle conversation pieces. Era inconfondibile il sentimento di claustrofobia che doveva venirgli dalle arti minori, dove si rispecchiava e ritrovava quel suo io: «Con i colori più caldi, con l’amorosa sensualità melodica che Tasso e Rubens avevano nutrito nella sua penna, – ha scritto Pietro Citati – provava a immaginare quella vita pura e senza oggetti che forse avrebbe potuto conoscere. Gli sembrava di aver fallito in tutto, riempiendo la casa di cose morte, uccidendo attimi incorporei di tempo possedendo un’esistenza che non gli apparteneva.» Tutto doveva restare immune dalla contaminazione del mondo, a prezzo dell’isolamento, perché tutto fosse perfetto e intangibile nella contemplazione della bellezza.
Ma la vita ha una forza incontrollabile e presenta svolte immoralistiche, completamente imprevedibili. Vicino a Mario Praz, esattamente al piano superiore della casa di via Zanardelli, dopo la lavorazione di Gruppo di famiglia in un interno (1974) di Visconti, per caso andò ad abitare Mario Schifano, che aveva dichiarato di voler abbandonare la pittura e dedicarsi al cinema, da lui giudicata arte viva. Detestava lo psicologismo di Bacon, non gli interessava Morandi, non lo riguardava Pollock, apprezzava Raushemberg come uomo e non come pittore. Amava de Chirico, Boccioni, Balla, Picabia, Picasso, Jasper Johns, Jim Dine. Come artista si dava alle più sperimentali incursioni maledettistiche fin nel mondo delle droghe pesanti e Praz era vistosamente imbarazzato di averlo come vicino. Schifano faceva un gran chiasso, era scomposto assordante ambiguo senza ritegno, inquinava il silenzio della sua solitudine, lo disturbava. Il professore era infastidito, aveva perso la pace, senza neppure ritrovare la vitalità smarrita nella perfetta collezione delle sue conversation pieces. Questa singolare situazione circolò nel mondo artistico-letterario romano dei primi anni Settanta, colpì Luchino Visconti, già malato, dopo la trilogia tedesca, per la portata profetica che il suo film veniva ad assumere in questa determinata circostanza. A Praz come alter-ego del regista e alle sue miniature, alla sua casa-museo, alla sua rinuncia al mondo esterno, alla defunzionalizzazione del suo sapere (e, d’altro canto, a Mario Schifano trasfigurato a posteriori nella volgare e attraente famiglia di inquilini, emblema dell’invivibilità del presente, che vengono a invadergli l’abitazione), si era infatti ispirato Enrico Medioli per il personaggio del professore. Visconti ne fece un Kammerspiel, un film-requiem tutto girato in interni, come a teatro, citando la Recherche, dove si parla di un inquilino immaginario al piano di sopra che si aggira, inquietante, misterioso, come una metafora della morte.